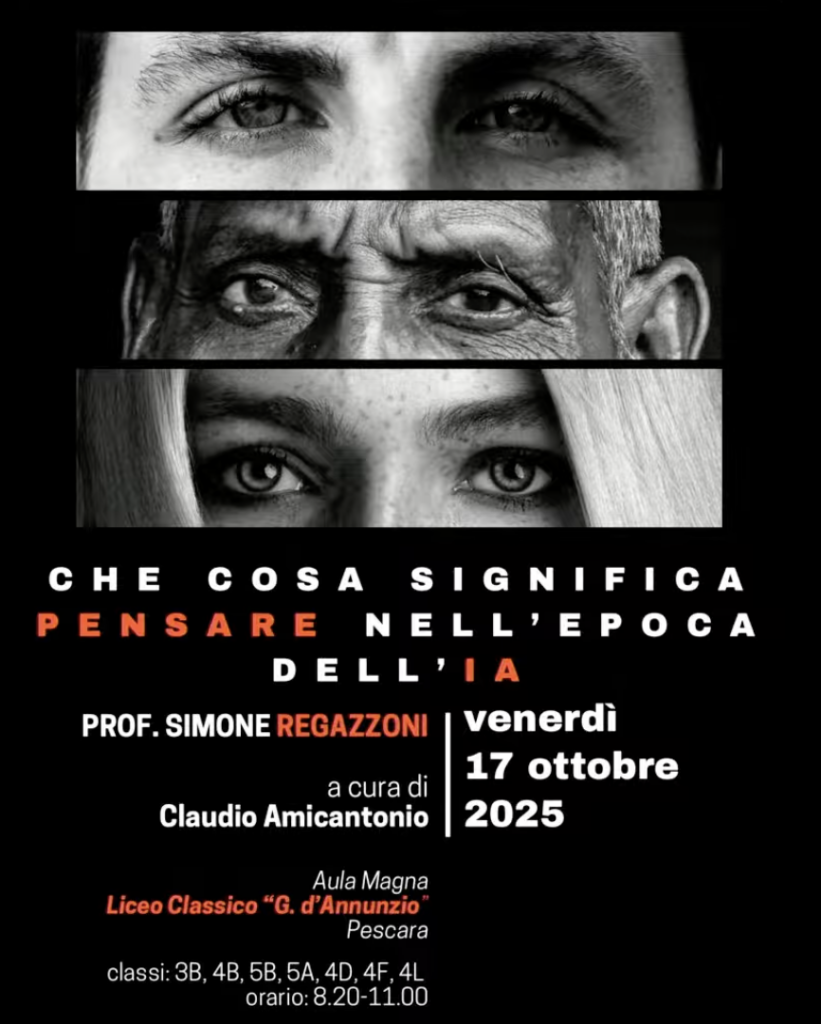“Parto da questo contesto, e da voi come interlocutori”: così il prof Simone Regazzoni ha introdotto un discorso che ha spaziato dagli ambienti delle scuole italiane, fino agli spogliatoi di box.
Il prof, in accordo con Chatgpt, ha astutamente sottolineato come le scuole siano il tessuto attraverso il quale il pensiero dell’intelligenza artificiale si muove verso interlocutori di primaria importanza, poiché saranno gli stessi che nel futuro dovranno trovare il modo adatto per interfacciarsi a questo “ente, strumento, oggetto? Vedremo cos’è” .
Nel suo intervento, Regazzoni ha fatto notare l’affermazione paradossale, ma tuttavia non apocalittica, di Stuart Russell, uno dei più grandi esperti contemporanei di intelligenza artificiale: “ Con l’intelligenza artificiale abbiamo tanto da guadagnare, ma anche tutto da perdere”. Innanzitutto, cos’è il tutto di cui parla Russell e che potremmo perdere? La specificità di ognuno di noi, che ci rende esseri umani, la nostra essenza. Come afferma Aristotele, noi siamo dotati del logos, che è quell’elemento che congiunge linguaggio e pensiero. Questi due elementi sono propri dell’uomo, ma oggigiorno è venuto a diventare caratteristica anche dell’IA: nel momento in cui si è appropriata della parola, ha determinato un’attenzione di massa, un’omologazione caratterizzante il pensiero, e non il modo di essere o di apparire, come i famosi “trend del momento” che appaiono sui nostri social quotidianamente.
Insieme a questi tratti che umanizzano l’IA, un altro elemento definisce il suo carattere pericoloso: “La promessa di un sapere totalizzante”. Da essa la risposta “non lo so” è impossibile in termini universali: conosce tutto, e il suo conoscere non presenta alcuna esitazione.
Ma la componente cruciale dell’IA è un’altra: garantire l’assenza della fatica; o meglio del “ponos”, una parola che ha permesso di costruire la filosofia: “filoponia”, ovvero amore per la fatica, poiché garantisce l’esperienza che ci permette di giungere alla costruzione di un sapere. E questo percorso esperienziale è essenziale, anzi, “più importante dell’acquisizione del sapere stesso”.
Questo diventa impossibile per Chatgpt, poiché produce sapere senza tenere conto dell’esperienza che capacita la trasformazione del soggetto, in modo da costruire noi stessi.
Il prof spazia poi sulla potenza creatrice del linguaggio, a partire dal quale si può costruire un mondo sia soggettivo sia esterno, nella nostra collettività. Ed è proprio nella vita collettiva che il linguaggio è “costituzione dello spazio del politico”: secondo le parole di Regazzoni, quest’ultimo è “un confronto tra logoi” nella nostra società, e sono proprio queste unità di logoi che “ci rendono più politici degli altri esseri viventi”.
Il linguaggio può essere tutto questo, ma un’obiezione potrebbe prendere essere: Chatgpt, come tutte le intelligenze artificiali degenerative, possiede un sapere-linguaggio (logos) superiore al nostro, poiché è uno strumento di cui si può fare un uso buono uno cattivo, in base agli scopi che noi mettiamo in atto per il nostro sapere. E ciò avviene poiché possiede un erudizione maggiore di qualunque essere umano, in grado di superarlo in ogni campo di competenza.
Ora, uno strumento, solitamente, è passivo rispetto alle nostre intenzioni; Nell’IA, non avviene ciò. E ancora, uno strumento possiede sempre un ente esterno in grado di manipolarlo; di nuovo, nel caso dell’IA, ciò non avviene, essendo uno strumento di cui non si conosce il funzionamento interno. Dunque, in questo senso, il prof afferma che “l’IA può essere vista come una tecnologia con una Black Box, una scatola nera, impenetrabile”, che trascende tutto ma non può essere trascesa.
A queste constatazioni, il pensiero umano tende ad attribuire all’IA una sorta di potenza magica, che va oltre i limiti della ragione, e nel nostro legame con essa mettiamo anche in atto degli atteggiamenti altrettanto irrazionali, ma che, secondo la nostra idea, sono in accordo con quei “poteri magici” che contengono queste tecnologie.
Una situazione che potrebbe destare molta instabilità, ma che al tempo stesso compensa quest’ultima sensazione con la certezza di un sapere illimitato, che ci faccia sentire invincibili e mai sbagliati.
Sam Altman, tuttavia, ha individuato il reale punto di rottura che secondo lui rappresenta il vero pericolo: il momento in cui un capo delle istituzioni o delle aziende, un filosofo, un pensatore o uno scrittore sentirà la necessità di prendere qualsiasi decisione consultando l’IA. Proprio in quel momento perderemo quella specificità di cui parlava Russell, perché il nostro pensiero sarà subordinato a quello dei chatbot.
Altman ha recentemente collaborato con Jony Ive, il progettista britannico che è stato “Chief Design Officer” presso Apple, per creare una forma di intelligenza artificiale che vada oltre un rapporto interfacciale, ma che arrivi a costituire un rapporto simbiotico con l’essere umano, dove la distinzione tra chi pensa, chi parla o chi ascolta viene messa in discussione. E infatti, Regazzoni in seguito afferma che tale progetto dovrebbe essere chiamato proprio “progetto io”.
Ma la distinzione tra noi e qualcosa che non ci appartiene diventa fondamentale in un mondo in cui si avverte una tendenza sempre maggiore alla simbiosi con un ente terzo, che viene dopo il nostro corpo e il nostro pensiero. Il prof affermerà poi che questi ultimi possono separarsi, come altrettanto dare luogo a un processo unitario, e approfondirà tale processo.
Regazzoni si recherà poi all’unione di tutte queste informazioni per codificare un messaggio proprio per gli alunni della scuola, da dove era partito: è necessario dare voce alla propria specificità, alla propria potenza vitale e linguistica, che possa anche convivere con l’IA, ma che non le permetta di soffocarla e di creare un mondo totalmente omologato. Così si impedirà, ad esempio, che i capi politici arrivino alla consultazione dell’IA per le loro decisioni, poiché saranno abbastanza consapevoli che la specificità della loro decisione può provenire solo da essi. DARE VOCE, questa è la parola d’ordine.
Molte domande entusiasmanti e curiose hanno seguito l’intervento del prof, risultato di riflessioni profonde, che hanno rafforzato le capacità critiche degli studenti.
A questa, prima conferenza dell’anno scolastico organizzata dal prof. Claudio Amicantonio, seguirà una lunga serie, accompagnando il percorso degli studenti.
Francesca Cipriani