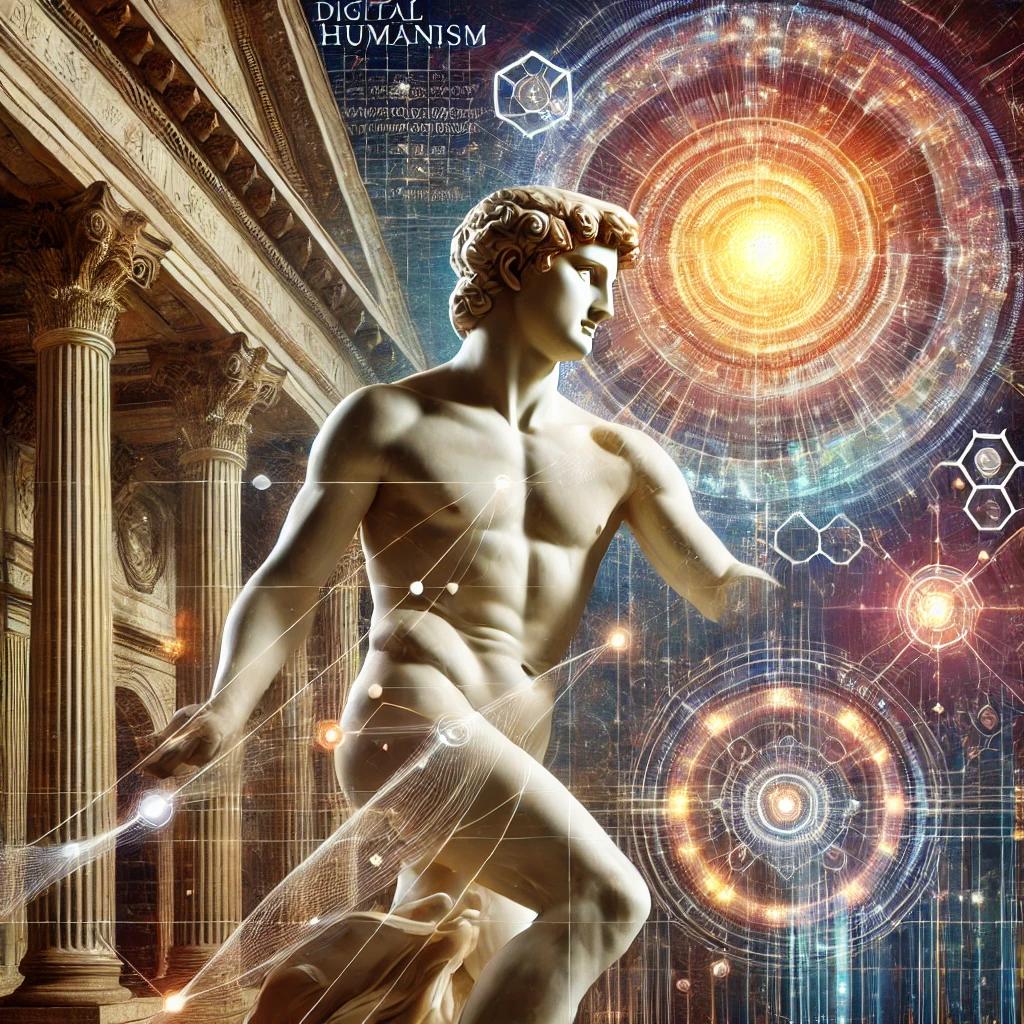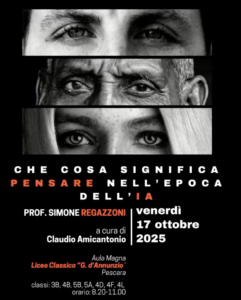Secondo Luciano Floridi, professore ordinario di Filosofia ed etica dell’informazione presso l’Oxford Internet Institute della Oxford University, che ha racchiuso i propri pensieri in merito ai sistemi d’informazione in uso nel XXI secolo in un suo scritto, intitolato “La quarta rivoluzione – come l’infosfera sta trasformando il mondo-” è utile rappresentare l’evoluzione umana in tre fasi: la preistoria, in cui non erano presenti ICT (ovvero tecnologie dell’informazione e della comunicazione), la storia, in cui le ICT hanno il compito di registrare e inviare informazioni ma ciononostante le società umane sono ancora dipendenti da altre tipologie di tecnologie, ed infine l’iperstoria (nella quale ci troviamo anche noi), in cui le ICT registrano, trasmettono e – fattore fondamentale – processano informazioni; così facendo rendono le società umane imprescindibilmente dipendenti dall’ICT. Altra conseguenza del periodo in cui ci ritroviamo a vivere è dunque la “volgarizzazione” -intesa in senso letterale – delle nuove tecnologie, in questo modo un potere sempre crescente sarà disponibile a costi irrisori per un numero sempre più vasto di persone, in quantità e velocità fino a poco tempo prima inimmaginabili.
Quali potrebbero essere ( o dovremmo più propriamente dire, saranno? ) dunque i cammini che saremo portati ad intraprendere, quale la meta? Sicuramente dovremo reimparare ad interagire, sia con le altre persone sia con altre forme intelligenti che assumeranno un ruolo di rilievo nella nostra vita. Ma come siamo effettivamente arrivati a questo? È finalmente giunto il momento di far entrare in campo il personaggio di Efesto, dio del fuoco, delle fucine, dell’ingegneria.
Il suo contributo sarà dunque essenziale per comprendere meglio tutte le sfumature di significato racchiuse nel termine greco αὐτόματος e, ovviamente, nel termine italiano a cui ha dato origine. Gli automi sono solitamente artefatti di metallo e la loro produzione è associata in gran parte al fabbro degli dei, in quanto custode della sapienza della tecnica. Il fatto che la presenza di questi automi sia testimoniata persino nei poemi omerici è riflesso della grande considerazione di cui beneficiavano le arti fin dall’età arcaica greca e del carattere misterioso e quasi magico che ad esse veniva associato. L’immaginario greco non era dunque vergine rispetto a questo tipo di considerazioni: ritenere che potesse esistere qualcosa dotato di νους che fosse diverso dall’uomo o da altre forme di vita allora conosciute, non era considerata blasfemia, a tal punto che molti miti annoverano fra i loro personaggi alcuni enti che noi, per intenderci, definiremmo automi.
Soffermandoci un attimo sull’etimologia del termine stesso, vedremo che già in origine era presente il concetto di autodeterminazione razionale, ma inteso in modo peculiare. L’aspetto interessante risiede nel fatto che il termine αὐτόματοv fa sì riferimento all’opera autodeterminata, ma anche al particolare movimento che ne consegue. Il termine ingloba in sé un significato più ampio, sia rispetto a ciò che è si muove per proprio arbitrio, sia rispetto a ciò che si genera in maniera spontanea.
Avendo dunque ben in mente cosa intendessero effettivamente dire gli antichi Greci ogni qual volta facevano ricorso ad una simile parola, possiamo dunque passare alla fase successiva, ovvero ragionare su quelle che a loro dire furono le magistrali creazioni dell’ultimo fra gli dei, il figlio di Zeus scaraventato giù dall’Olimpo che ottenne il suo riscatto grazia alla propria tecnica.
Come accennato, anche qui l’importanza dei poemi omerici è vitale, proprio perché ci forniscono una prima testimonianza scritta di questo termine, che a noi risulta ormai tanto misterioso quanto prima invece poteva sembrarci famigliare. Aὐτόματοç in riferimento a degli oggetti lo ritroviamo in due casi principali. Un primo è quello riferito ad una disposizione, voluta dagli dei, che prevedeva che le porte del cielo (ουρανός), ovvero quella nube che cela la dimora degli dei, si aprissero da sé, seppur comunque su ordine delle Ore. Nel secondo caso invece, è usato come termine caratterizzante i famosi tripodi mobili costruiti da Efesto: oggetti artificiali che si muovono necessariamente per svolgere una determinata funzione.
La società omerica era infatti completamente assoggettata all’agire dagli dei, del resto questi ultimi, come Efesto, ma anche Atena, erano i custodi dei preziosi segreti delle arti, ad esempio quelli relativi alla lavorazione dei metalli o dei tessuti. Eppure, a dirla tutta, gli stessi dei hanno avuto bisogno di apprendere l’arte (τέχνη), a cui ormai vengono associati, da dei maestri.
Questa riflessione ci catapulta nuovamente nel mondo contemporaneo: chi sono i nostri maestri? Chi è veramente in grado di istruire le future generazioni su come comportarsi di fronte alle nuove forme assunte dell’IA e su come imparare a gestirle e a crearne di nuove, sempre più efficienti e complesse? Anche noi avvertiamo il bisogno, come gli dei olimpici, di trovare ciascuno un proprio insegnate-Ciclope che gli suggerisca tutti i segreti di un’arte che è ancora solo alle fasi iniziali di un lungo sviluppo.
La tecnica: dalla cucina di Efesto all’IA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.